Mi è stato chiesto perchè uso in preferenza gli smalti.
 L'uso degli smalti nelle mie opere è una scelta consapevole, che nasce dalla volontà di non fare compromessi con la materia. Gli smalti, per me, sono un linguaggio puro, che non ammette sfumature o mezze misure. Ogni pennellata che applico o getto che eseguo sulla tela è una dichiarazione netta, un'affermazione di presenza e di intensità. Non c'è spazio per l'indecisione; lo smalto non permette di tornare indietro, ogni gesto diventa definitivo. In questo senso, è l'ideale per i lavori che richiedono una tensione interiore, che voglio trasmettere senza mediazioni.
L'uso degli smalti nelle mie opere è una scelta consapevole, che nasce dalla volontà di non fare compromessi con la materia. Gli smalti, per me, sono un linguaggio puro, che non ammette sfumature o mezze misure. Ogni pennellata che applico o getto che eseguo sulla tela è una dichiarazione netta, un'affermazione di presenza e di intensità. Non c'è spazio per l'indecisione; lo smalto non permette di tornare indietro, ogni gesto diventa definitivo. In questo senso, è l'ideale per i lavori che richiedono una tensione interiore, che voglio trasmettere senza mediazioni.
Quando dipingo, lo faccio con un trasporto che va oltre l'atto tecnico. Ogni singola opera nasce da un impulso profondo, spesso un richiamo alla riflessione filosofica e esoterica che pervade il mio essere. Per me, creare arte non è solo un atto estetico, ma un viaggio interiore, una ricerca di significato. Ogni colore, ogni forma, ogni linea che traccia la mia mano è una risposta a domande più grandi, che risuonano nell’universo come eco di un mistero che cerco di cogliere e di esprimere.
Soprattutto, credo che il mio modo di dipingere non sia solo una tecnica, ma una filosofia di come voglio creare iul mio divenire nell’arte. Ogni opera è il risultato di un dialogo silenzioso con me stesso, con l’energia che mi circonda, e con quel mondo invisibile che ci collega tutti. L’esoterismo e la filosofia sono il fondamento che dà profondità alla superficie della tela.
Dal libricino "Confusione" pubblicazione di Pulcinoelefante
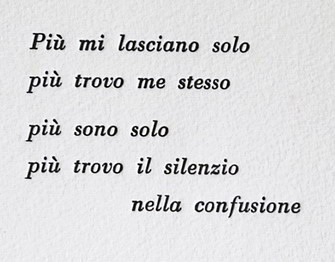
La solitudine, per me, è una condizione intrinseca dell’esistenza umana, uno spazio interiore che può spaventare, ma che, se accolto, diventa un alleato prezioso. Non è l'assenza di persone a farmi sentire solo, ma la qualità delle relazioni che ho intorno. Spesso ripenso a Nietzsche e a quel passaggio di Zarathustra che dice: "La mia solitudine non dipende dalla presenza o assenza di persone; al contrario, io odio chi ruba la mia solitudine, senza, in cambio, offrirmi una vera compagnia." È così: le connessioni superficiali, in un mondo che ne è colmo, non fanno altro che distrarmi dalla mia essenza. Il silenzio, invece, mi aiuta a riscoprirla.
Stare soli è un’arte, una competenza che richiede tempo e pazienza per essere coltivata. Quando mi concedo il privilegio della solitudine, mi immergo in un dialogo profondo con me stesso. Non nego che spesso mi parlo ad alta voce. Non è pazzia, ma un modo per dare forma ai miei pensieri, per renderli più chiari. In quegli istanti di riflessione mi trovo a esplorare le mie aspirazioni, i miei timori e anche le mie contraddizioni. È lì che, lontano dagli sguardi altrui e dal peso delle aspettaative, scopro chi sono davvero. La solitudine, così, diventa un laboratorio interiore, il luogo dove il mio essere si forgia.
Eppure, non vedo la solitudine come una condizione permanente. La sua bellezza sta proprio nella sua transitorietà, come una pausa che dà valore alle note di una melodia. Se si prolunga troppo, rischia di trasformarsi in isolamento, e so bene quanto questo possa logorare l’anima e alimentare il senso di vuoto. Per questo cerco di distinguere tra la solitudine scelta, che mi arricchisce, e quella imposta, che mi impoverisce.
C’è un altro aspetto che mi fa riflettere: il senso della compagnia. La compagnia autentica non serve semplicemente a colmare un vuoto, ma a creare un ponte tra due solitudini. È qualcosa che nasce dalla comprensione reciproca, dalla capacità di essere presenti senza invadere, di dare senza pretendere. Mi infastidiscono profondamente quelle persone che rubano la mia solitudine senza offrirmi una vera connessione. Sono ladri di tempo ed energia. Al contrario, la vera compagnia è un dono che arricchisce entrambe le parti, uno scambio sincero che valorizza l’unicità di ciascuno.
E allora mi chiedo: quanto mi fa bene stare da solo? La risposta, lo ammetto, non è sempre chiara. Per me la solitudine è spesso un rifugio, un luogo dove posso essere libero, ma so anche che non può essere un rifugio permanente. L’equilibrio è la chiave: saper stare solo per conoscermi e crescere, ma anche scegliere con cura chi voglio accanto a me lungo il mio cammino.
In fondo, la solitudine è uno specchio che riflette chi sono e chi voglio essere. Quando la accetto come un’alleata, smette di essere una minaccia e si trasforma in una strada verso la libertà interiore. Solo allora scelgo di aprirmi agli altri, non per bisogno, ma per il desiderio autentico di condividere la mia umanità.
Riparare, Non Eliminare: Un Inno al Valore delle Cose.
 Viviamo in un’epoca in cui il consumismo domina le nostre scelte e ci spinge a sostituire ciò che si rompe con qualcosa di nuovo. Questo ciclo incessante non solo impoverisce il nostro legame con gli oggetti, ma contribuisce a uno spreco insostenibile che minaccia il nostro equilibrio con la natura.
Viviamo in un’epoca in cui il consumismo domina le nostre scelte e ci spinge a sostituire ciò che si rompe con qualcosa di nuovo. Questo ciclo incessante non solo impoverisce il nostro legame con gli oggetti, ma contribuisce a uno spreco insostenibile che minaccia il nostro equilibrio con la natura.
Un oggetto non è solo materia, ma anche memoria. Quel vaso scheggiato, quella sedia con una gamba traballante, non sono semplicemente oggetti rotti: sono testimoni del nostro tempo, frammenti di vita che abbiamo vissuto. Ripararli non significa solo dare loro una nuova funzione, ma rispettare il valore che hanno avuto nel nostro percorso. Eliminandoli, eliminiamo una parte di noi stessi.
Questa cultura del "ripara e conserva" si oppone alla logica del consumismo, che ci vuole in un ciclo perpetuo di produzione, acquisto e scarto. È un sistema che trasforma risorse preziose in rifiuti a una velocità che la natura non può sostenere. L’uomo, tuttavia, non è un circuito chiuso in armonia con il pianeta. Non ricicliamo noi stessi come fa la natura, ma ci comportiamo come estranei che sfruttano e abbandonano.
Ogni oggetto riparato è un piccolo atto di resistenza contro lo spreco, un gesto di consapevolezza che sottolinea l’importanza di rallentare, di apprezzare ciò che abbiamo, e di riconnetterci con un sistema di vita più sostenibile. Riparare significa non solo preservare le cose, ma anche coltivare una forma di gratitudine per la loro esistenza e il loro contributo al nostro quotidiano.
La via verso un futuro migliore passa anche attraverso scelte apparentemente piccole: riparare, conservare, proteggere. Solo così possiamo sperare di riequilibrare il nostro rapporto con la Terra e con noi stessi.
 L'uso degli smalti nelle mie opere è una scelta consapevole, che nasce dalla volontà di non fare compromessi con la materia. Gli smalti, per me, sono un linguaggio puro, che non ammette sfumature o mezze misure. Ogni pennellata che applico o getto che eseguo sulla tela è una dichiarazione netta, un'affermazione di presenza e di intensità. Non c'è spazio per l'indecisione; lo smalto non permette di tornare indietro, ogni gesto diventa definitivo. In questo senso, è l'ideale per i lavori che richiedono una tensione interiore, che voglio trasmettere senza mediazioni.
L'uso degli smalti nelle mie opere è una scelta consapevole, che nasce dalla volontà di non fare compromessi con la materia. Gli smalti, per me, sono un linguaggio puro, che non ammette sfumature o mezze misure. Ogni pennellata che applico o getto che eseguo sulla tela è una dichiarazione netta, un'affermazione di presenza e di intensità. Non c'è spazio per l'indecisione; lo smalto non permette di tornare indietro, ogni gesto diventa definitivo. In questo senso, è l'ideale per i lavori che richiedono una tensione interiore, che voglio trasmettere senza mediazioni.


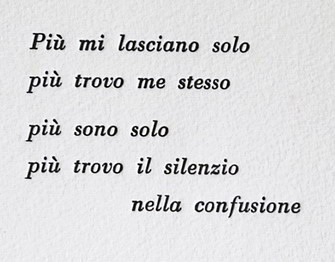
 Viviamo in un’epoca in cui il consumismo domina le nostre scelte e ci spinge a sostituire ciò che si rompe con qualcosa di nuovo. Questo ciclo incessante non solo impoverisce il nostro legame con gli oggetti, ma contribuisce a uno spreco insostenibile che minaccia il nostro equilibrio con la natura.
Viviamo in un’epoca in cui il consumismo domina le nostre scelte e ci spinge a sostituire ciò che si rompe con qualcosa di nuovo. Questo ciclo incessante non solo impoverisce il nostro legame con gli oggetti, ma contribuisce a uno spreco insostenibile che minaccia il nostro equilibrio con la natura. Accostarsi al kintsugi significa abbracciare molto più di una tecnica: è un viaggio nella filosofia dell'imperfezione e del recupero. Tuttavia, chi si avvicina a questa pratica oggi deve comprendere che ciò che viene proposto nel nostro tempo è spesso una reinterpretazione moderna.
Accostarsi al kintsugi significa abbracciare molto più di una tecnica: è un viaggio nella filosofia dell'imperfezione e del recupero. Tuttavia, chi si avvicina a questa pratica oggi deve comprendere che ciò che viene proposto nel nostro tempo è spesso una reinterpretazione moderna. Penso che essere 'patafisico oggi voglia dire soprattutto mantenere l’ironia e resistere al conformismo. È un modo per sfidare dogmi e convenzioni attraverso l’umorismo, evitando di cadere nella trappola della standardizzazione culturale e intellettuale. Non si tratta solo di un esercizio mentale, ma di una vera e propria filosofia di vita: esplorare l’assurdo e ciò che è marginale può diventare una chiave per reinterpretare la realtà.
Penso che essere 'patafisico oggi voglia dire soprattutto mantenere l’ironia e resistere al conformismo. È un modo per sfidare dogmi e convenzioni attraverso l’umorismo, evitando di cadere nella trappola della standardizzazione culturale e intellettuale. Non si tratta solo di un esercizio mentale, ma di una vera e propria filosofia di vita: esplorare l’assurdo e ciò che è marginale può diventare una chiave per reinterpretare la realtà. In termini filosofici, il Kurinuki può essere visto come una meditazione sulla transitorietà e sull'imperfezione, concetti centrali nella filosofia giapponese del *wabi-sabi*. Attraverso la pratica del Kurinuki, l'artigiano si confronta con la materia prima in modo diretto e immediato, accettando e valorizzando le imperfezioni che emergono nel processo. Ogni pezzo diventa una testimonianza del momento presente, dell'interazione tra l'artista e l'argilla, e dell'unicità irripetibile di quell'incontro.
In termini filosofici, il Kurinuki può essere visto come una meditazione sulla transitorietà e sull'imperfezione, concetti centrali nella filosofia giapponese del *wabi-sabi*. Attraverso la pratica del Kurinuki, l'artigiano si confronta con la materia prima in modo diretto e immediato, accettando e valorizzando le imperfezioni che emergono nel processo. Ogni pezzo diventa una testimonianza del momento presente, dell'interazione tra l'artista e l'argilla, e dell'unicità irripetibile di quell'incontro. L'idea alla base del kintsugi è quella di celebrare le cicatrici e le imperfezioni dell'oggetto invece di nasconderle. Questo processo mette in evidenza il concetto giapponese di "wabi-sabi", che abbraccia l'idea che la bellezza può essere trovata nella naturalezza e nell'imperfezione delle cose.
L'idea alla base del kintsugi è quella di celebrare le cicatrici e le imperfezioni dell'oggetto invece di nasconderle. Questo processo mette in evidenza il concetto giapponese di "wabi-sabi", che abbraccia l'idea che la bellezza può essere trovata nella naturalezza e nell'imperfezione delle cose. L'arte del Raku rappresenta una forma unica di ceramica, originaria del Giappone, che si è diffusa con grande successo in tutto il mondo. Questa tecnica si distingue per il suo processo di cottura particolare, che conferisce ad ogni pezzo un aspetto inimitabile e profondamente espressivo. Gli artisti Raku, attraverso la loro maestria, riescono a trasformare semplici pezzi di argilla in vere e proprie opere d'arte, ricche di texture, colori e sfumature che catturano lo sguardo e il cuore di chi le osserva.
L'arte del Raku rappresenta una forma unica di ceramica, originaria del Giappone, che si è diffusa con grande successo in tutto il mondo. Questa tecnica si distingue per il suo processo di cottura particolare, che conferisce ad ogni pezzo un aspetto inimitabile e profondamente espressivo. Gli artisti Raku, attraverso la loro maestria, riescono a trasformare semplici pezzi di argilla in vere e proprie opere d'arte, ricche di texture, colori e sfumature che catturano lo sguardo e il cuore di chi le osserva.